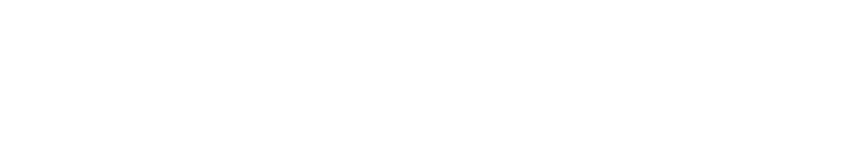Fine XVI secolo
Ignoto pittore cartografo locale
Pianta del territorio di Varese con la Selva detta Penna
Disegno a penna dipinto ad acquerello su foglio unico, mm 400 x 1470
ASGe, Manoscritti, 593
Questa rappresentazione raffigura una porzione del tratto appenninico costituita dal monte Penna e dai suoi versanti sud orientali degradanti fino al corso del fiume Taro. L’attribuzione a Cristoforo Grassi, compiuta sulla base di una lettura comparativa con altra carta, è di E. Marengo (1931), ma M. Quaini (1983) e D. Moreno (1990) suggeriscono piuttosto la mano di un pittore cartografo locale.
L’oggetto principale della cartografia, la Selva della Penna, la rende una delle più antiche “carte forestali” prodotte nei territori della Repubblica di Genova.
Il monte Penna è uno dei rilievi più importanti dell’asse principale dell’Appennino ligure orientale, con 1.730 m di quota. Dal 1550 al 1805, il monte era collocato a intersezione tra i territori della Repubblica, i feudi Doria Pamphili e gli stati del Duca di Parma.
Il cartografo rappresenta la vetta rocciosa, evidenziata con la scritta «La penna». Parte dei toponimi o degli elementi confinari salienti (ad esempio «comincia la Selva della penna») sono scritti direttamente sul foglio, mentre altri sono stati aggiunti successivamente con minute etichette (ad esempio «la Tagliata»).
La Selva della Penna era un bosco “camerale”, entrato in possesso dello Stato genovese nel 1547, e adibito specificatamente a produrre uno speciale assortimento di pezzi di faggio diritti e lunghi almeno dieci metri (detti, nella documentazione contemporanea, come «fo’ diritti et longhi») per la costruzione dei remi delle galee.
La veduta mostra i versanti del massiccio montano con la copertura vegetale: aree boscate (poste in sommità, negli impluvi secondari e lungo il corso del fiume), pascoli nudi («pradarie»), e pascoli alberati e nuclei abitati o “ville”, come la «la menta villa di Compiano», circondate da campi permanenti, forse terrazzati. In particolare, le «pradarie» erano stazioni prative caratterizzanti il paesaggio del piano submontano, la cui estensione bene testimonia l’economia dell’allevamento in cui i boschi erano utilizzati per il pascolo estivo di bestiame bovino e ovino che gravitava attorno alla Selva. Le greggi ovine, ancora alla fine del XVIII secolo, raggiungevano numerose la selva in estate anche dai centri della sottostante Riviera di Levante.
Lungo la linea confinaria ancora oggi la vegetazione è costituita da una faggeta governata a ceduo, con parziali rimboschimenti primo novecenteschi di Pinus nigra e Abies alba.
Nella carta sono sottolineate le colture e le semine temporanee. Queste pratiche avevano una valenza legittimatrice della giurisdizione e del possesso degli spazi; questa carta deve essere stata realizzata nell’ambito di un conflitto liminare con i Landi, come testimonia la scritta «Territorio di Varese benché preso da Landesi» riportata su un prato pascolo alberato.
La carta testimonia anche un sapere faunistico locale: la gestione multipla dei pascoli arborati di faggio doveva avere anche un effetto di “attivazione” nei confronti della piccola fauna selvatica, come dimostrato dalle pasciute lepri raffigurate dal cartografo.
Scheda di Nicola Gabellieri, tratta da:
Sulle tracce dei pastori in Liguria. Eredità storiche e ambientali della transumanza,
a cura di Nicola Gabellieri, Valentina Pescini e Daniele Tinterri, Genova 2020. Catalogo della mostra tenuta all’Archivio di Stato di Genova dal 16 settembre al 5 dicembre 2020.